LESTER PIÙ #13
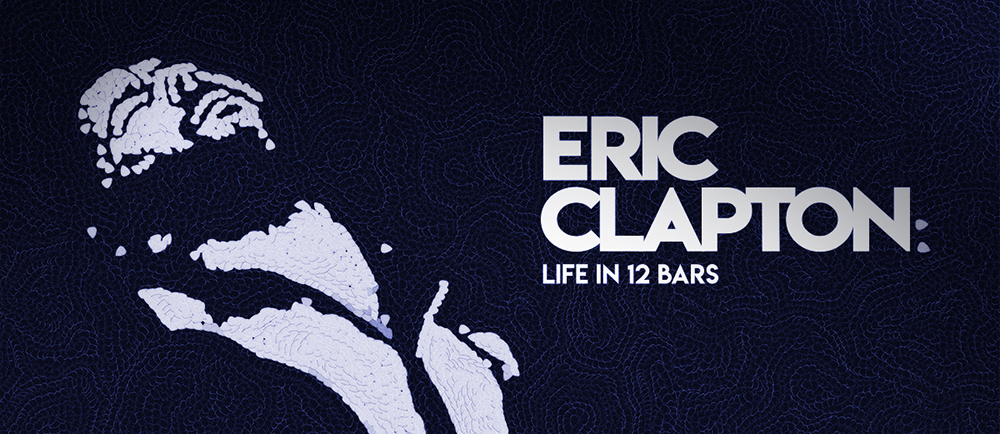
Un documentario torrenziale che promette molto bene
A vederlo oggi, questo distinto ed azzimato signore ormai settantenne, si direbbe una persona serena e rilassata e forse, il signor Clapton, classe 1945, è davvero sceso a patti con i suoi demoni. Eppure, quando si perde totalmente nella musica, quando comincia a far vibrare di piacere le corde della sua chitarra, con quel suo tocco indolente ma deciso e libidinoso – che gli ha procurato il meraviglioso ed azzeccatissimo soprannome Slowhand –, qualcosa del ragazzaccio di un tempo continua inevitabilmente a saltare fuori.
Perché “cattivo ragazzo”, Eric Clapton, lo è stato per davvero. Ragazzino scontroso e problematico, che già giovanissimo trovava sfogo alla sua insoddisfazione tentando di replicare nota per nota, sulla sua Hoyer acustica, i vecchi dischi blues che giravano per casa. La svolta arriva quando quella cricca di giovani teppisti che corrisponde al nome di Yardbirds, lo chiama a militare tra le sue fila, per suonare un po’ di quel blues che tanto piace al giovane Eric – nel frattempo il ragazzo si è fatto un nome, suonando in piccoli complessi di provincia – ma con una violenza ed un tasso di decibel mai sentiti prima.
Il rapporto dura poco, giusto il tempo di piazzare qualche hit di successo, ma Clapton è un purista, il blues è la sua fede, così finisce sotto l’ala protettiva di qualcuno che la musica del diavolo la mastica e la venera anche più di lui: John Mayall. Le ormai leggendarie incisioni con i Bluesbreakers pongono le basi della mitologia claptoniana. Dopo quel fondamentale disco (ed il tour che ne segue), sui muri di Londra cominciano ad apparire le prime scritte che paragonano Clapton a Dio, anche se lo scettro gli sarà presto rubato da un giovane chitarrista americano di colore in trasferta, con tante idee per la testa ed un approccio del tutto innovativo allo strumento (ma questa è un’altra storia).
Il resto, è storia di pubblico dominio: l’entusiasmante sbornia psichedelica dei Cream, l’epoca dei supergruppi, con compagni di via del calibro di Steve Winwood e Duane Allman (insieme al quale firmerà Layla, una delle più struggenti e meravigliose dichiarazioni d’amore di tutta la storia del rock), l’alcool, la droga, il decennio degli ’80 che lo porterà sulle vette della pop music (ma a tradire quella che è la sua vera indole), la gioia della nascita di un figlio, la tragedia della sua improvvisa ed assurda morte, l’abisso, la riscoperta delle radici, la rinascita.
Una storia che meriterebbe ben altro spazio per essere raccontata in maniera esauriente, motivo più che sufficiente, quindi, per fiondarsi al cinema il 26, 27 e 28 febbraio, giorni in cui uscirà, come evento speciale, Eric Clapton: Life in 12 Bars, torrenziale film documentario (135 minuti di durata, promette molto bene) diretto da Lili F. Zanuck, che si propone, tramite filmati d’epoca ed accurate interviste ai diretti interessati, come un ottimo compendio di un percorso artistico straordinario, travagliato ed assolutamente degno di essere raccontato con dovizia di particolari, per un uomo che il Blues, oltre ad averlo predicato e portato a vette spesso inarrivabili, lo ha vissuto e sperimentato sulla propria pelle. (Angelo D’Elia)




